Automotive, componentistica italiana in frenata: i dati dell’Osservatorio ANFIA 2025
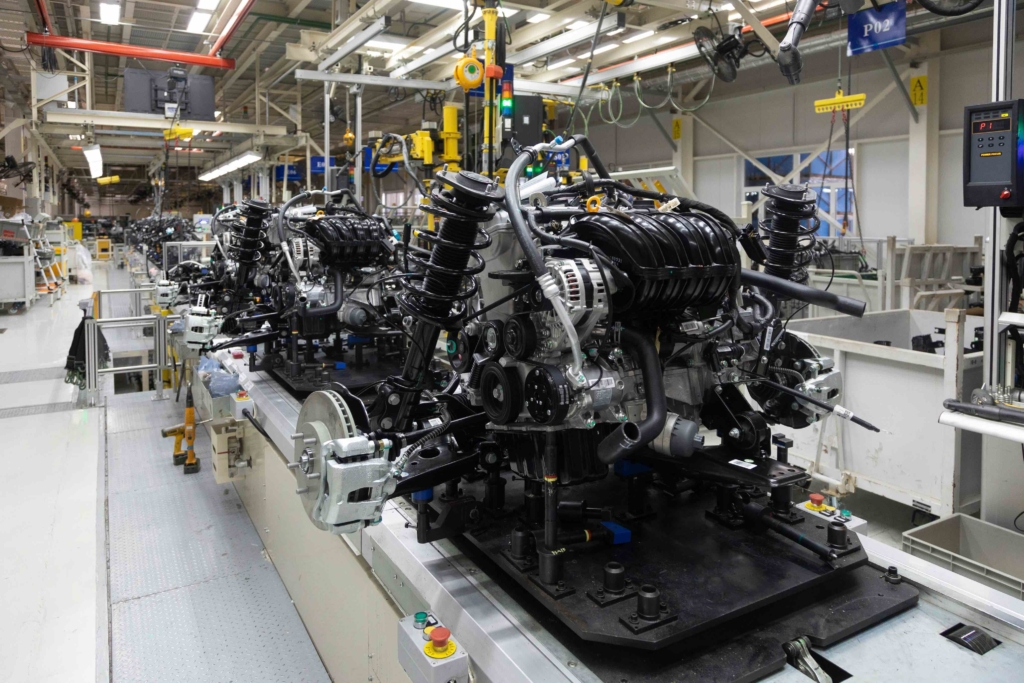
Pubblicato il 20 Ottobre 2025
Il settore della componentistica automotive italiana ha tirato il freno a mano. È questa la fotografia scattata dall’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana e sui servizi per la mobilità 2025, la consueta indagine annuale realizzata da ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) e dalla Camera di commercio di Torino.
I dati, presentati lo scorso 15 ottobre all’Auditorium del MAUTO di Torino, evidenziano la fine di un periodo di crescita e delineano un futuro caratterizzato da forte incertezza e marcato pessimismo.
I numeri di un settore in crisi
L’universo della componentistica in Italia è costituito da 2.134 imprese con sede legale nel Paese. Nel 2024, queste realtà hanno registrato un fatturato complessivo direttamente riconducibile all’automotive pari a circa 55,5 miliardi di euro.
Tuttavia, dopo tre anni di risultati complessivamente favorevoli, il 2024 ha segnato una contrazione nettadei ricavi del 6,0% a livello nazionale rispetto all’anno precedente. Anche l’occupazione ha subito un lieve calo, attestandosi a 168.085 addetti, con una flessione dello 0,7%.
Analizzando le categorie di fornitori, le contrazioni maggiori del fatturato hanno colpito i fornitori di moduli e integratori di sistemi, scesi dell’8,2%, e gli specialisti, in calo del 7%.
Gli unici segmenti in grado di mostrare resilienza e crescita sono stati gli specialisti del motorsport (+1,2%) e, in particolare, l’aftermarket (+0,6%). Questi ultimi, operando prevalentemente per il parco veicolare circolante, si confermano come il cluster meno condizionato dal contesto di cambiamento.
Il Piemonte, regione leader in Italia per numero di imprese del settore con 717 unità (il 33,6% del totale nazionale), riflette pienamente la tendenza negativa: il fatturato stimato delle aziende piemontesi è calato del -5,6%, raggiungendo circa 19,9 miliardi di euro. La situazione occupazionale nella regione è risultata particolarmente critica, con una riduzione degli addetti più marcata rispetto al dato nazionale, pari al -2,4%, scendendo a 59.682 unità.
Il contesto: incognite globali e transizione energetica
La flessione dei ricavi si inserisce in un quadro globale di forti incertezze geopolitiche, crisi internazionali e un sensibile spostamento del baricentro produttivo mondiale verso l’Asia. Mentre la domanda mondiale di autoveicoli è cresciuta (+2,8% nel 2024), l’Europa ha perso peso relativo, e la produzione domestica italiana di autoveicoli ha chiuso il 2024 con un crollo a doppia cifra (-32,3%).
Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di commercio di Torino, ha sottolineato come l’incertezza sia generata da fattori concomitanti, quali la transizione energetica, la rapida avanzata dell’area asiatica e l’introduzione di dazi. In questo panorama complesso, il 62% delle imprese indagate, rispetto al 36% del 2023, ha dichiarato una contrazione del proprio giro d’affari nel 2024.
Un elemento cruciale che pesa sulle prospettive del comparto è la transizione mono-tecnologica focalizzata sull’elettrico. Un approccio che secondo Marco Stella, presidente del Gruppo Componenti ANFIA, sta danneggiando i componentisti europei: i loro prodotti coprono circa il 60% del contenuto tecnologico dei veicoli con motore a combustione interna (ICE), ma solo il 40% circa nei veicoli elettrici. Questo pone il rischio di perdere fino al 23% del valore aggiunto entro il 2030, secondo stime CLEPA. Per questo motivo, ANFIA auspica una revisione della normativa europea sulle emissioni che valorizzi un approccio tecnologicamente neutrale, includendo i carbon neutral fuels.
Le strategie aziendali, infatti, sono fortemente condizionate non solo dalle politiche delle case automobilistiche europee (ritenuto rilevante per l’86% degli operatori) e dall’instabilità economica globale (86%), ma anche dai crescenti timori legati all’ingresso dei costruttori cinesi in Europa (fattore di alta rilevanza per il 52% degli operatori) e all’introduzione di dazi (47%).
Tendenze tecnologiche e prospettive future
Nonostante le difficoltà, la filiera sta cercando di definire il proprio posizionamento tecnologico in un mercato in rapida evoluzione. La maggior parte degli operatori, per la precisione il 77,1%, si concentra sulla componentistica destinata a qualsiasi tipologia di veicolo, indipendentemente dall’alimentazione. Parallelamente, una quota significativa (38,2%) continua a presidiare la filiera dei motori a combustione interna.
Sebbene il coinvolgimento in progetti per il powertrain elettrico stia tornando ad aumentare (24,8% delle imprese), le attività legate a sistemi alternativi come fuel cell a idrogeno risultano ancora più contenute. Tuttavia, è proprio nello sviluppo di tecnologie legate al fuel cell che si registra una significativa crescita nell’intenzione futura di partecipazione (15,2%).
L’attività innovativa resta costante, con il 54% delle imprese che ha introdotto innovazioni di prodotto nel triennio 2022-2024. Per quanto riguarda l’Intelligenza Artificiale (IA), la sua diffusione è ancora limitata, con il 59,9% delle aziende che non la applica. Ciononostante, il 20% prevede di sperimentare o implementare l’IA entro i prossimi tre anni. La ricerca di nuovo personale è orientata soprattutto verso figure specializzate nello sviluppo di software e app (50%) e nella gestione ambientale ed energetica (47,3%).
Previsioni 2025: un pessimismo diffuso
Il quadro atteso per il 2025 è marcatamente negativo, con previsioni peggiori rispetto all’anno precedente. Solo il 20% delle imprese italiane prevede un aumento del fatturato, mentre il 63% stima una riduzione, portando il saldo a un significativo -43%.
Le difficoltà maggiori riguardano gli ordinativi interni e le vendite sui mercati esteri, entrambi previsti in calo. Anche sul fronte occupazionale, il saldo è fortemente negativo (-39%). Oltre la metà degli operatori (53%) prevede tagli al personale. Già nel primo semestre del 2025, il 38% delle imprese è dovuto ricorrere ad ammortizzatori sociali, con ampio utilizzo della CIGO (Cassa Integrazione Ordinaria).
Di fronte a questo scenario, le imprese continuano a chiedere alle istituzioni interventi mirati, in primis per il contenimento dei costi dell’energia (83%) e per la creazione di un fondo di supporto alla transizione industriale a livello nazionale ed europeo (75%). La richiesta di estensione della Cassa Integrazione Guadagni (CIG) , inoltre, ha visto crescere sia la valutazione di efficacia passata che la sua priorità per il futuro imminente (56%).




